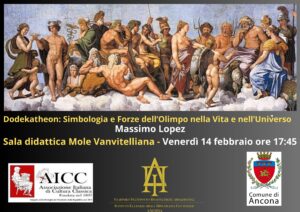Amore e coraggio non sono soggetti a processo

Quando Robert Brasillach (1909 – 1945) scrive questi versi ha 36 anni. È rinchiuso nel carcere di Fresnes accusato di «intelligenza col nemico» per essersi schierato dopo la resa della Francia con i nazionalsocialisti. Non si fa illusioni, sa che la sentenza di condanna a morte è già scritta anticipatamente e a nulla varranno gli appelli alla clemenza rivolti a de Gaulle da intellettuali e scrittori d’ogni parte politica, da Albert Camus a François Mauriac, da Paul Claudel a Paul Valery (solo i livorosi Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir si rifiutarono di sottoscrivere la domanda di grazia).
La fucilazione, avvenuta la mattina del 6 febbraio 1945, pone fine alla parabola umana e artistica di un intellettuale tra i più rappresentativi di quel movimento culturale e politico che Paul Serant definirà icasticamente «romanticismo fascista».
I versi citati nel titolo sono tratti da Il testamento di un condannato, una lunga composizione in ventiquattro ottave, che riecheggia quella famosa di Villon, ma dove, a differenza di questa, è assente l’irriverenza e il tono giocoso ed è presente invece una lacerata drammaticità. Ne riportiamo i versi iniziali e finali:
«A trentacinque anni
prigioniero come Villon,
incatenato come Cervantes
condannato come Andrea Cheniier,
prima dell’ora dei condannati
come in altri tempi
su questi fogli scarabocchiati
inizio il mio testamento.
Per sentenza dei miei beni terreni
mi si vuol togliere il possesso.
È facile, non ho terre
o tesori nel mio retaggio.
E i miei libri, le mie visioni
possono essere dispersi al vento:
amore e coraggio
non sono soggetti a processo. […]
Qualche ombra, qualche immagine
ha ancora diritto a qualche briciola:
affrettiamoci dunque nella spartizione
prima che si compia il destino.
Tutti coloro, uomini o donne,
che sono entrati nel mio cammino
possono nella notte lucente
aspettare il mattino con me.
Per tutti loro avevo mani traboccanti:
esse ora sono vuote
dei ricordi più lontani
e del passato più commovente.
Non conservo da portare,
al di là della vita terrena,
lontano dai piaceri umani,
che quelle che furono le mie amicizie,
solo ciò che non si può strappare,
l’amore e il gusto della terra,
il nome di quelli che vengono
nel mio cuore nelle notti tristi:
gli anni della mia felicità,
la fiducia dei miei fratelli,
e sempre il pensiero dell’onore
e l’immagine di mia madre.»
Nel carcere Brasillach si affida alla preghiera e alla scrittura. Scrive un saggio sul poeta Andrea Chenier, il «fratello dal collo mozzato»; la Lettera ad un soldato della classe ‘40, che è un bilancio della sua vita e una sorta di testamento spirituale in cui si rivolge alle future generazioni rivendicando, al di là degli errori commessi, le sue scelte politiche; e i Poemi di Fresnes, una raccolta di poesie che vibrano di umana pietà per la sorte di tutti i condannati senza distinzione, di tutti gli umiliati ed offesi, nonché di virile dignità di fronte al destino e di amore per la patria:
«Altri sono passati di qui
i loro nomi sui muri muffiti
già si scrostano e si cancellano.
Hanno sofferto e sperato
e talvolta la speranza s’avverava,
altre volte moriva tra queste mura.
Venuti di qui, venuti da altri luoghi
non avevamo lo stesso cuore,
così ci è stato detto: bisogna crederlo?
Ma che importa quel che eravamo!
I nostri volti soffocati dalla nebbia
si somigliano nella notte nera.
È a voi, fratelli sconosciuti,
che penso, quando giunge la sera.
Oh miei fratelli avversari!
Ieri è vicino all’oggi.
Nostro malgrado siamo uniti
nella speranza e nella sciagura.
Penso a voi, voi che avete sognato,
penso a voi, a voi che avete sofferto,
voi di cui oggi ho preso il posto.
Se domani ritroveremo la libertà,
i nomi che si sbriciolano sui muri
non saranno forse la nostra parola d’ordine?»
In quello straordinario romanzo a sfondo storico-politico, che è I Sette colori (1939), in cui sono mescolati, capitolo dopo capitolo, tutti i generi letterari, dall’epistola all’aforisma, dal monologo al diario, dalla narrativa al teatro, il poeta aveva scritto: «Ogni età ha la sua bellezza e questa bellezza deve sempre essere libertà. Soltanto la libertà e la bellezza del trentesimo anno, sfuggite all’adolescenza, minacciate dall’avvenire, sono per la prima volta congiunte alla lucidità». E poco oltre: «A trent’anni l’uomo e la donna trovano la perfezione del piacere; l’ardore, l’impeto, la potenza, ma anche la sua scienza, la sua lentezza. I due giovani corpi che la nudità ringiovanisce, hanno l’uno per l’altro l’attenzione, la premura la precauzione dell’amicizia. In riva al piacere si aspettano, come due nuotatori, e possono attendersi, e possono non attendersi a lungo. […] È il miracolo di quegli anni, fragile quanto il miracolo dell’adolescenza, e forse è il solo autentico compenso apportato dal tempo».
E non a torto il culto di Brasillach per la giovinezza è stato colto lucidamente dal saggista Alessandro Barbera che in un articolo su Nuovo Confronto metteva in rilievo come lo scrittore francese «resta essenzialmente il cantore della giovinezza; di un’età intensa e meravigliosa e pure breve e fugace, da cui il rimpianto che essa genera col suo finire». E proseguiva: «è proprio l’amore per la giovinezza ciò che spinge Brasillach verso il fascismo e sarà questo amore a costargli la vita. Un fascismo vissuto e sentito in chiave poetica, ma non per questo colto superficialmente».
In una delle sue poesie più significative dei Poemi di Fresnes, Brasillach scriveva:
« Il mio paese mi fa male per le sue vie affollate,
per i suoi ragazzi gettati sotto gli artigli delle aquile insanguinate.
Per i suoi soldati combattenti in vane sconfitte
per i giuramenti non mantenuti,
per il suo abbandono e per il suo destino
e per il grave fardello che grava i suoi passi. […]
Il mio paese mi fa male per tutti i suoi esili,
per le sue prigioni troppo piene, per i suoi giovani morti,
per i suoi prigionieri ammassati dietro il filo spinato,
e per tutti quelli che sono lontani e dispersi.
Il mio paese mi fa male con le sue città in fiamme,
male contro i nemici e male con gli alleati,
il mio paese mi fa male nel corpo e nell’anima
sotto i pesanti ferri dai quali è legato. […]
Il mio paese mi fa male per la sua falsità da schiavi,
con i suoi carnefici di ieri e con quelli di oggi
mi fa male col sangue che scorre,
Il mio paese mi fa male. Quando riuscirà a guarire?»
(Il mio paese mi fa male)
Il poeta francese nei suoi testi ha voluto lasciarci una toccante testimonianza esistenziale e poetica e indicarci una via: «la custodia delle uniche virtù in cui aveva sempre creduto: la fierezza e la speranza» (Pino Tosca).
Sandro Marano