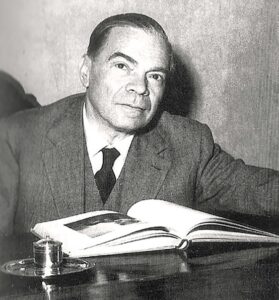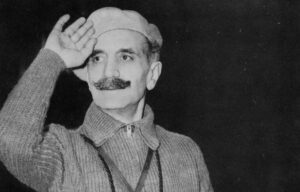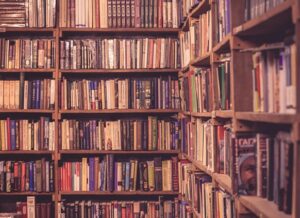Il canto galla

«Ad orecchio amoroso l’altopiano
rivela i suoi segreti. Si dipana
la matassa di note dai grovigli
acuminati delle acacie
cercano le iene col loro corteggio urlante
altre piste e le aree mietute
si stendono alla luna.
Strappa il vento ai folti delle rogge
le piume perdute dei nibbi
e a refoli i fiocchi
il canto galla della mietitura
i cori del raccolto attorno ai fuochi
le voci alterne unisone virili
di fanciulli e di femmine.
Ero nascosto nell’ombra del podocarpo
dove il vento portava acri ceneri e voci
la guerra è finita da tanto
ma il teff non ha cessato di granire
nel giro di stagioni desolate.»
È questa la prima delle due strofe di cui si compone la poesia di Franco Silvestri (1916- 1997) Il canto galla, che dà il titolo alla raccolta pubblicata nel 1985. Il canto dei Galla, l’etnia maggioritaria dell’Etiopia, che unisce nella mietitura del teff (un cereale tipico di quei luoghi) uomini donne e fanciulli, nasconde – ci dice subito dopo il poeta – un «dio domestico e antico», «che beveva quel canto come un tributo», quasi a simboleggiare quella sintonia di umano naturale e divino, da cui lui, giovane ufficiale in Africa orientale al comando di bande irregolari di guerriglieri etiopici, fu, affascinato e per sempre segnato. E ai suoi commilitoni Silvestri dedicò un libriccino di memorie Cappella marca visita (1937) che rappresenta il suo esordio letterario.
Combattente in Africa orientale durante la seconda guerra mondiale, dopo una lunga prigionia in India, al suo ritorno, oltre a dedicarsi alla professione di avvocato e alla politica nelle file del MSI, svolse un’intensa attività letteraria, di conferenziere, di promotore di cultura, di giornalista. Fu tra l’altro direttore del mensile Nuovo confronto, al quale anche noi collaborammo. Tra le sue opere ricordiamo il conciso e superbo saggio Vanvitelli e il suo tempo (premio Vanvitelli 1974), lo scritto del 1987 dedicato ad Araldo di Crollalanza, Araldo di Crollalanza Un uomo, una città con la prefazione di Giorgio Almirante e il libro di racconti Tempo d’Africa del 1994.
Così lo ricordava in un articolo apparso su Meridiano sud nel settembre 1995 il saggista Alessandro Barbera:
«Franco Silvestri fu […] formalmente un fascista, un neofascista. Ma il suo fascismo era venato di spirito liberale. […] fu sempre aperto al dialogo con gli altri. Silvestri fu l’espressione di un ceto borghese che al Sud soprattutto aveva ereditato i modi signorili delle vecchie aristocrazie […] Il passaggio dal MSI ad AN lo lasciò interdetto. Non mancò di esprimere le sue perplessità».
Ma torniamo al poeta e alla sua poetica dalle «studiatissime immagini» e dalla «raffinata soavità lirica» (Donato Valli), che fa tesoro sia della lezione dannunziana (in particolare quella del Poema paradisiaco) sia di alcune innovazioni dell’ermetismo. Le sue poesie hanno una costruzione sintattica semplice e piana ed insieme un lessico ricercato, preciso nei dettagli, ricco di figure retoriche, dove spiccano magnifiche similitudini e personificazioni, come nell’incipit di questa poesia:
«Taranto dolce e disarmata patria di acque
oasi di mare tra rive inesplorate
il grido del pescatore come un gabbiano
si posa sulle onde con solitario linguaggio
con magico richiamo con inviti ancestrali
le canne rabbrividiscono»
(La mensa degli ingegneri)
La raccolta si snoda intorno a tre temi fondamentali che si intrecciano strettamente: l’amore, l’esperienza africana e la “Puglia segreta”. Il ricordo d’Africa e il sentimento d’amore per la donna amata procedono di pari passo:
«Ho scordato di chiederti in quale mercato
del giovedì, sull’altopiano, hai comprato
questa bianca e rada tela d’Etiopia
che so chiamarsi futa e tu chiami ghebbì.
[…]
e la sabbia ha limato e disperso in turbini
gli amori di ieri e di ieri la nostra vita.
Noi in questo lenzuolo dovremmo rivivere
e ritrovare i nostri corpi di allora
la nostra anima di rugiada di allora
di allora la frenesia di cercarci
oltre la morte, oltre il terrore delle notti
sull’altopiano gelido, con scarse parole
aggrappati alla nostra solitudine».
(Per una futa che chiami ghebbì)
Quanto alla “Puglia segreta” è questa una tipica espressione del poeta:
«Vento radente del mare
sul sagrato della cattedrale
e sulle mura della città notturna
una Puglia segreta, un sibilo di fronde
e all’uscio della bettola il vento
mugolante nel vicolo».
(Elegia del pescatore)
La critica più autorevole osserva come l’appartenenza di Silvestri ad una tradizione, ad una storia ben precisa e all’amato Salento, non gli impediscano di abitare poeticamente luoghi diversi: se «il centro vero della poesia di Silvestri può e deve essere indicato in quella patria remota che è la Puglia segreta» (Vittorio Vettori), anche l’Africa orientale, anche l’esilio, possono diventare una Patria e il poeta non a caso esclama: «tutto il mondo è stato il mio Salento» (Una patria remota).
A ben guardare, la “Puglia segreta” di Silvestri, fatta di vento, di canti, di amori, di memorie, di odori e di sapori, si allarga all’intero mondo dove ha amato e vissuto:
«Anche dove lasciammo i nostri morti
è patria
mare e cielo e monti deserti
sono patria
patria le rive lontane
patria è la nostra nostalgia
ed è più della morte amaro
l’esilio dei morti».
(Amaro esilio dei morti)
Silvestri poi tocca con grande efficacia e originalità il tema dell’amore, con le sue pene e le sue gioie, le sue titubanze e il suo disincanto. Come nei versi di questa lirica, Una luna che passa, che è senz’altro tra le più belle della raccolta:
«Scegliamoci, amici, una luna deserta che passi
una cometa col velo di sposa
così personale e remota
che transiti gloriosa e segreta per sempre
e senza aurore di sangue
nello spazio non lungo né breve
del nostro amore
il tempo che il tuo volto si rischiari
alla luce della lanterna del porto
nel clamore del mare.
La chiameremo con nome di fantasia
la chiameremo illusione la chiameremo
una luna che passa.»
Il poeta ci invita ad abbandonarci all’amore, al suo incantesimo, pur nella consapevolezza della sua illusorietà, della sua fugacità, del suo essere, appunto, una luna che passa.
Sandro Marano