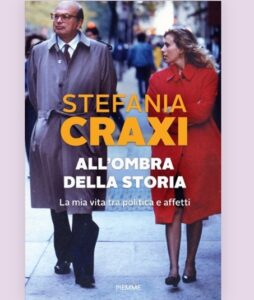Quando gli alberi erano miei fratelli
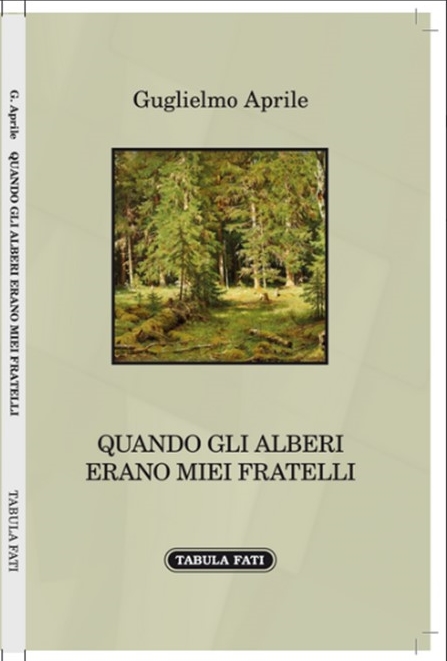
L’ultima prova in versi di Guglielmo Aprile, Quando gli alberi erano miei fratelli (Tabula Fati Edizioni, 2024), è una sorta di immersione obliante e stupefatta nell’universo vegetale, di cui l’autore esplora poeticamente il variegato ventaglio di rimandi ai saperi mitologici e antropologici e alla storia delle religioni. Consacrare un’intera raccolta all’indagine della relazione tra l’uomo e l’albero, in tutti gli sfaccettati risvolti simbolici ed esistenziali che essa implica, conduce e quasi condanna a un monotematismo ossessivo, incentrato su una specifica ed esclusiva espressione della vita naturale, alla quale l’osservazione dell’autore si vota con una dedizione estatica e intransigente che rasenta i modi del culto, come il poeta apertamente dichiara in Dendrolatria (p.96). Ma estrarre dall’humus di questa verde passione materia di poesia, sempre che quest’ultima sappia guardarsi dalle trappole del facile idillio o di un superficiale intimismo, significa misurarsi con tutto quel ricco substrato di “favole antiche”, vichianamente intese, di leggende che fra loro si intrecciano come fanno i rami che si allargano dal tronco, in architetture dalla trama sontuosa ed elaborata, e che avevano il pino e l’alloro, il mandorlo e il tiglio come protagonisti, ambientate in quel “tempo prima del tempo”, stando ad una delle definizioni che Mircea Eliade diede del mito, in cui non era ancora sedimentata la cortina tra i regni dell’umano e del naturale e tra l’universo materiale e il divino, al punto che le metamorfosi, i passaggi dall’una all’altra di tali dimensioni, erano possibili e le ierofanie ricorrenti; non a caso, l’ombra di Ovidio aleggia in diverse pagine dell’opera di Aprile, in particolare nella sezione intitolata Teofanie silvestri (pp.55-69), nella quale si fa più esplicita la rievocazione della vicenda fantastica di quelle creature che, ora per il castigo e ora per la pietà degli Dei, videro la propria pelle mutarsi in corteccia lignea e gli arti e i capelli ricoprirsi di fogliame.
Certamente il nutrito bagaglio sapienziale che sostanzia questa scrittura può costituire un limite per il lettore comune, non aduso a contenuti così peregrini per la sensibilità odierna, dimentica del ruolo ricoperto dal frassino o dalla betulla nei riti sciamanici di certe popolazioni primitive, dei legami che il druidismo celtico stabiliva con la quercia, nonché del valore archetipale che certi alberi assumevano in diverse culture arcaiche, che tributavano ai più imponenti e maestosi membri della stirpe che abita i boschi il ruolo di axis mundi, a cui si richiama un testo della silloge come Culto dell’albero (p.57), reminiscenza dell’emblema dell’albero cosmico, il pilastro centrale che con la sua verticalità connetteva le regioni celesti, la superficie della terra e i baratri inferi, secondo la triplice suddivisione in cui la creazione era articolata nelle cosmogonie di un lontano passato. Siamo insomma al cospetto di un testo che esala un sentore di inattualità, rafforzato anche dalla preziosità retorica e musicale del linguaggio di cui è intessuto, incline a un canone formale aristocratico, che volentieri indulge all’aggettivazione sfarzosa e a concessioni auliche sul piano lessicale; ma l’impressione che queste pagine donano è paragonabile al silenzio, quasi mistico e risonante di fremiti misteriosi, che si respira in un bosco, in uno di quei santuari che hanno tronchi per colonne e per cupola il cielo, che il frastuono assordante della città non osa violare, e nel quale le urgenze contingenti sembrano sfumare, come scrutate dal crinale di una abissale lontananza, in una vertigine di quiete atemporale. E se gli alberi ospitano nel loro cuore silente “tutte le tempeste / che terrore o delirio partoriscono” (Pietà degli alberi, p. 85), allora è indirettamente di noi umani che attraverso la loro voce il poeta sta parlando, mettendo a nudo gli slanci e i trasalimenti, i tremori e gli smarrimenti del nostro animo, e saldando quella frattura storica provocata dallo sviluppo in senso antropocentrico della civiltà, che ha separato dalla comunità degli altri esseri l’unica specie dotata di pensiero cosciente, isolandola in una orgogliosa quanto arida pretesa di superiorità su tutte le altre creature; eppure, non appena il soggetto lirico è riammesso alla compagnia di un filare di pioppi o di una cerchia di olivi sul fianco di una collina, il sollievo di un ricongiungimento alla propria essenza, da lungo tempo atteso e sospirato, pare invaderlo e ricolmarlo in ogni fibra.
Nei momenti più alti della sua ispirazione, lo sguardo dell’autore legge nell’albero un simbolo dell’armonia universale; ciò è evidente in particolare nei testi conclusivi del libro, culmine di un itinerario iniziatico che approda alla rivelazione “che al di sopra del mondo che crediamo / reale e dei suoi veli debba esserci / non visibile ai nostri occhi un ordine // meraviglioso, un senso che trascende / le nostre capacità di comprenderlo” (Armonia degli alberi, p. 96). La concezione di fondo sottesa all’opera è che ogni apparenza del teatro naturale palpiti di vita e sia pervasa di anima: quasi un retaggio animistico, che la poesia vorrebbe resuscitare, o un tentativo di fondare un moderno panpsichismo, che con il mito condivide l’intuizione che tutte le cose si appartengano, siano connesse da una rete di corrispondenze, fino a fondersi in un tutto organico e senziente – il Pan dei Greci, nume tutelare della poesia di Aprile, come egli stesso riconosce in Regno di Pan , p.59 – e a ricomporre quell’unità che ha in ogni aspetto della multiforme realtà sensibile la propria luminosa irradiazione.
Antonio Peragine